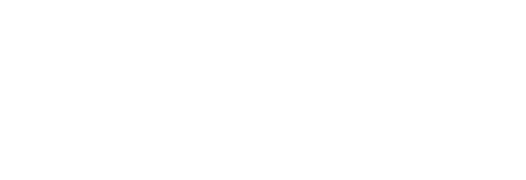In bilico tra la sicurezza dei locali e quella dei militari impiegati in missione: è lo stato d’animo di chi opera fuori area in teatri operativi instabili, ma anche l’elemento cruciale che ricorre dalle pattuglie sul terreno fino alle sale operative.
In bilico tra la sicurezza dei locali e quella dei militari impiegati in missione: è lo stato d’animo di chi opera fuori area in teatri operativi instabili, ma anche l’elemento cruciale che ricorre dalle pattuglie sul terreno fino alle sale operative.
Quello che è successo a Herat ieri – una tredicenne uccisa apparentemente da fuoco italiano in un contesto di inequivocabile tensione, amplificato dall’attuale deterioramento dell’area afghana occidentale dove si rincorrono addirittura voci di probabili attentati – porta da un lato all’apertura di due inchieste da parte della magistratura e dall’altro a una maggiore consapevolezza dei rischi presenti anche per i nostri peacekeepers.
Portare la pace evidentemente non è così semplice e indolore. Cinque anni fa, in occasione del cambio di comando Isaf dai turchi agli italiani, a Kabul l’allerta era alta, così alta da temere attacchi repentini. Alle pattuglie in uscita dalla base si ripresentava ogni volta il dilemma: e se ci viene incontro un bambino che non ferma la sua corsa neppure quando gli si intima chiaramente di allontanarsi? Cosa si fa? Si spara?
Bene ha detto il capo di stato maggiore italiano di Isaf, generale Marco Bertolini, riportato oggi da La Stampa: “Le lacrime di una madre afghana sono come quelle di una madre italiana: dobbiamo tenere insieme il rapporto con questa gente e la salvaguardia dei nostri soldati che qui rischiano la vita tutti i giorni”.
Bertolini ha usato chiarezza senza eufemismi nel far presenti anche i rischi che i nostri soldati corrono quotidianamente. E pur se ogni pattuglia è costantemente collegata via radio alla base, le minacce sono davvero improvvise e imprevedibili. Come la Toyota Corolla bianca che ieri mattina a Herat sembrava impazzita nella sua corsa verso i blindati italiani sotto la pioggia battente.
Immagine: nato.int