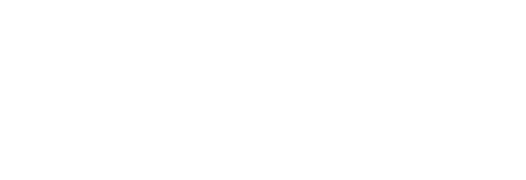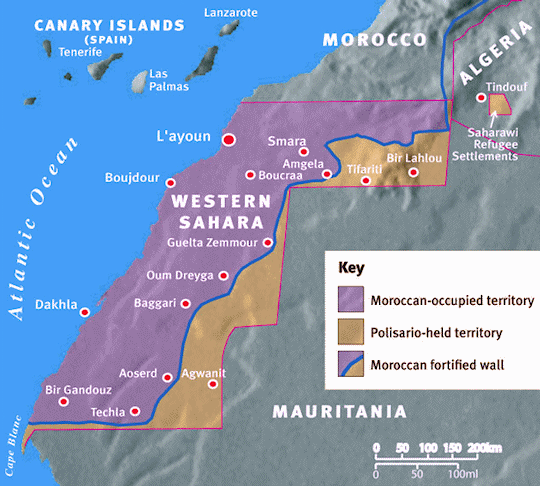L’identità alla prova della guerra
La guerra è stata uno dei fattori di coesione per la società saharawi, fungendo da catalizzatore per rendere concreta e salda un’identità che fino a quel momento era rimasta ancora su un piano eminentemente teorico. In altre parole fu il banco di prova – perché momento di difficoltà in cui si arrivò a dare la vita per essa – della nazione saharawi, sia per i combattenti al fronte, sia per i civili nei campi dei rifugiati.
Si può datare l’inizio della guerra saharawi con la nascita del Fronte Polisario e l’attacco della piccola guarnigione spagnola a El-Khanga (maggio 1973) e la sospensione – visto che di fine non si può parlare – con il cessate il fuoco monitorato dalla MINURSO il 6 Settembre 1991. Nell’arco di questi 18 anni di guerra cambiarono sia i nemici – per i primi due anni fu la Spagna, poi la Mauritania fino al 1979 e definitivamente il Marocco – sia le tecniche di attacco e difesa – guerra, guerriglia, muro – e questo periodo rappresentò il momento di maturità della popolazione saharawi.
Il protagonista di questa guerra fu l’Armata Popolare di Liberazione Saharawi (APLS), fondato in concomitanza del Fronte Polisario – con cui condivideva praticamente la maggioranza dei membri – il 10 maggio 1973.
Se il numero di effettivi non superava i 1.500 nel 1976, al momento del ritiro degli Spagnoli l’APLS incorporò circa 3.000 ausiliari con le loro armi e il loro equipaggiamento, così come dei nomadi venuti dal Mali e dalla Libia. Furono inquadrati in battaglioni, katā’ib (singolare katiba), compagnie leggere di un centinaio di uomini che potessero spostarsi velocemente, sul modello di quelle algerine del Fronte di Liberazione Nazionale. Il momento di maggiore sforzo fu tra il 1977 e il 1980, quando i combattenti furono sempre più difficili da trovare, ma dal 1980 e il 1984 le truppe passarono da circa 4.000 a 10.000 uomini. In generale però, il numero degli effettivi è rimasto piuttosto stabile grazie alla strategia di guerriglia, che non esponeva mai l’APLS ad un confronto in campo aperto che si sarebbe rivelato esiziale, data la disparità delle forze in campo.
L’esercito di popolo
La prima particolarità che distinse l’APLS fin dai primi anni fu un certo egualitarismo tra i suoi membri, condizione inconsueta in un ambiente inevitabilmente gerarchico come quello dell’esercito. Tutti – dal generale fino al più modesto dei combattenti – mangiavano lo stesso pasto, portavano le stesse uniformi e vivevano insieme sulla base delle medesime condizioni. Ciò non solo era una traduzione nella realtà dei proclami dai tratti più socialisti del Polisario, ma rifletteva la necessità di vivere la coesione nazionale ad ogni livello e ad ogni ruolo, come nei campi dei rifugiati così nell’esercito. Come nei campi non circolava moneta, così non c’era una paga nell’esercito. L’esperienza della guerra rappresentò un capitolo fondamentale nel processo di aggregazione nazionale, anche perché fu l’esperienza più immediata dell’alterità.
L’identità si rafforzò in funzione e in opposizione all’altra identità – nello specifico quella marocchina – rappresentando nello stesso tempo un momento in cui esplicitare questa differenza e la necessità di serrare i ranghi.
“Tutti quanti partono volontariamente, secondo la propria volontà. Nel Sahara c’è questo, che nessuno può obbligarti a fare niente. E’ qualcosa che non trovi nel resto del mondo, cioè che nessuno ti può obbligare.
D’altronde nel nostro esercito per esempio, tutti si rispettano tra loro. […] Là sono passati molti momenti… c’è un momento in cui per esempio perdi un amico, va bene? Un vecchio amico, che è stato con te tutto il tempo… Queste cose sono indimenticabili. Sono molte, e ognuno ha la sua.”
Ognuno di questi momenti va a far parte di un patrimonio di memoria storica collettiva che allontana definitivamente qualsiasi soluzione alternativa all’autodeterminazione in uno Stato sovrano.
In questo breve tratto di intervista appare molto forte il tema della volontarietà – e, di riflesso, della determinazione – dei Saharawi nel combattimento. Non c’è costrizione, ma una sorta di imperativo morale da parte della società a concepire attivamente la propria immagine – negata da altri – di popolo. Al superamento di questa negazione partecipano praticamente tutti: da una parte le donne e i feriti a sostenere lo sforzo organizzativo nei campi, dall’altra gli uomini che ereditano dall’immaginario tribale il ruolo di protagonista nel teatro bellico.
Alla domanda “com’era la vita nell’esercito?” mi è stato risposto:
“Ragazzo, la vita in qualsiasi esercito non è come la vita normale. Questo in ogni esercito, ma soprattutto nel nostro, solo che il nostro si differenzia dalla maggior parte degli eserciti per questa condizione: noi ci riuniamo tra noi, per prendere il tè e parlare e così via. Questo a pranzo, a cena, in ogni momento. Poi negli altri eserciti ciascuno con il suo panino o quello che è, infatti noi grazie alle nostre abitudini, perdiamo questa mancanza di stare ciascuno per sé, per esempio se vuoi parlare con un amico o se vuoi mangiare da solo, noi mangiamo insieme, parliamo insieme, leggiamo il Testo insieme e la nostra vita ci ha favorito molto, non siamo come i marocchini, per esempio.
I marocchini, ogni marocchino mangia la sua latta di sardine, vive da solo. Noi no, noi viviamo tutti insieme, parliamo di tutto insieme, della guerra, delle donne, del passato, di tutto, del futuro, di tutto. E così poi siamo più allegri, più.. ammazziamo il tempo, per esempio i giorni passano senza rendersene conto. Stiamo lì per un po’, poi ogni tanto andiamo in permesso ai campi dei rifugiati, e quello che ha famiglia la vede, o che ha moglie e ci sta quindici o venti giorni”
Quando si parla della guerra come condivisione di un’esperienza comune, si intende condivisione ai livelli più elementari della vita militare. Uno dei tratti distintivi (“il nostro si differenzia dalla maggior parte degli eserciti”) è il trascorrere la maggior parte dei momenti in comune. Questo aspetto della vita militare riflette il lavoro di integrazione a tutti i livelli per portare ad una detribalizzazione completa della società intera, compreso – a maggior ragione – il settore militare. L’elemento distruttivo insito nelle divisioni tribali può essere ritrovato nel testo nella parola “mancanza” – nell’originale in spagnolo “falta”: un esercito che non ottempera alla condizione di condivisione è un esercito come gli altri, schiavo della costrizione. Quello saharawi – in quanto volontario e unito – non mostra segnali di debolezza e addirittura viene ammantato nell’estetica saharawi di valori quasi esclusivamente positivi – “i giorni passano senza rendersene conto”.
“Gli piaceva tantissimo la vita, anche se non stava prendendo niente, né materiale né benessere, niente, gli piaceva solo combattere contro i marocchini per ottenere l’obiettivo finale, che è la liberazione del Sahara Occidentale e per far tornare i rifugiati saharawi a quei luoghi degli altri”
Queste sono le parole di un combattente della prima ora. La mancanza di materiale e la durezza di condizioni si riferiscono al primo periodo, quello in cui – piuttosto sconosciuti a livello internazionale – i soldati saharawi erano costretti praticamente ad autofinanziarsi la guerra con razzie nei depositi marocchini. Nonostante ciò, anche qui risulta ben chiaro il discorso impostato dal Polisario: qualunque sofferenza patita momentaneamente perde di forza davanti al male maggiore, l’esilio dal Sahara Occidentale. Il ritorno al suolo natio, rivoluzione concettuale per un popolo che nasce nomade, resta l’obiettivo finale, il punto di arrivo di una serie infinita di azioni militari, segno che il riferimento identitario è definitivamente legato al territorio. Il momento del ritorno assume un valore quasi utopico, ma resta l’obiettivo ben chiaro per tutti – in particolare per quelli che hanno combattuto:
“Per me, nella mia opinione, non è arrivato il momento, il miglior momento della mia vita perché non abbiamo ancora l’indipendenza, perché non abbiamo fino ad oggi uno Stato indipendente per i Saharawi. Per questo mi manca un momento indimenticabile, per questo mi manca il miglior momento della mia vita.”
La strategia
Dopo un inizio traumatico – in cui il Reale Esercito Marocchino mise in campo tutta la sua potenza in una guerra di movimento che opponeva due armate convenzionali – il conflitto divenne meno classico. In particolare nel 1977, al terzo congresso del Fronte Polisario, furono create le regioni militari e innovati i sistemi di armamento (mitragliatrici sui blindati, carri T.55), sopperendo all’esiguità del numero dei combattenti saharawi con una potenza di fuoco maggiore e una pianificazione delle battaglie più attenta, che consentisse una netta divisione dei compiti tra i reparti. Questo continuo adattamento alla realtà storica e geografica del territorio, permise di mantenere un livello operazionale stabile e piuttosto regolare: degli attacchi quasi quotidiani e, ogni due anni, delle offensive maggiori. Eppure in partenza le difficoltà erano tali che pochi avrebbero potuto supporre la sopravvivenza della resistenza saharawi.
In effetti la capacità militare dell’APLS non potrebbe essere spiegata se non alla luce dell’apporto logistico, militare, tecnico di altri paesi e movimenti di liberazione.
Per primo intervenne il colonnello Gheddafi, che, negli anni della formazione del Polisario, aveva dato avvio a una strategia di sostegno ai movimenti di liberazione nazionali contro i regimi coloniali; oltre a fornire supporto militare, la Libia era una delle destinazioni privilegiate per i giovani Saharawi, i quali studiavano soprattutto nelle scuole militari.
Cuba, oltre al supporto diplomatico e tecnico, inviò nel 1976 200 soldati dal contingente in Angola per formare i militari dell’APLS; in più offrì posti ai giovani Saharawi per la formazione superiore, ospitando i giovani per tutta la durata dei loro studi.
L’Algeria fu la principale sostenitrice della causa Saharawi, fungendo da sponsor diplomatico per il mondo, nonché lasciando una parte – seppur la più inospitale – del proprio territorio perché alloggiasse i campi dei rifugiati, sostenendo economicamente da sola l’esistenza di questi ultimi per molti anni. In più – oltre ad ospitare la maggior parte degli studenti saharawi – fornì sostegno logistico e militare completo all’APLS.
I militanti socialisti e i movimenti di liberazione – come quelli della Guinea Bissau, dell’Angola e del Vietnam – portarono un know-how forgiato dall’esperienza nel campo della guerriglia e della contro-guerriglia di stampo americano e francese, principali consiglieri della strategia marocchina. Anche la neonata Repubblica Islamica Iraniana, in reazione all’aiuto apportato dal Marocco allo Shah, ospitò dei Saharawi perché venissero addestrati, così come è certo che 80 membri del Fronte Polisario siano stati formati nei campi di Hezbollah nel Beqaa sotto controllo siriano.
In breve tempo, grazie a questa sorta di “cooperazione internazionale” su base ideologica – socialista o anti-imperialista – l’APLS dispose di armi di tutti i calibri: armi pesanti, T.55 sovietici, carri, blindati, veicoli da trasporto, cannoni da 90 mm d’artiglieria pesante e armamenti di fanteria con capacità anti-aerea. L’arma più importante tra queste fu però indubbiamente il Thin Skinned che – più potente delle jeep Land Rover – permetteva di coprire anche 1.000 chilometri senza rifornimenti. Questo tipo di armamenti rifletteva il tipo di conflitto che l’APLS avrebbe combattuto: guerriglia o guerra asimmetrica, data la disparità di risorse e di strategia tra i due contendenti.
Nella prima fase l’APLS condusse attacchi sporadici – ma insistenti – su numerosi fronti, andando a colpire le zone più sensibili sotto controllo marocchino – El-Ayun e le miniere di Bou Craa – e la liquida frontiera con la Mauritania. Nel 1976 Nouakchott fu attaccata e presa da 600 Saharawi armati pesantemente, azione in cui morì uno dei fondatori e capo indiscusso del Polisario, El Wali Mustapha Sayed. Lo shock per il fragile paese africano fu comunque terribile e, in tre anni, la Mauritania firmò una pace e le Reali Armate Marocchine dovettero sostituire completamente le impreparate truppe mauritane.
Nel 1979 il Polisario, con un raid spettacolare che destò ancora maggiore impressione, attaccò addirittura la zona di Tan Tan, in territorio marocchino non contestato. La battaglia più dura, in termini di perdite da entrambe le parti, fu la battaglia di Smara dell’ottobre 1979, che fece più vittime dei quattro anni precedenti sommati insieme.
La strategia utilizzata dal Polisario si articolava in due condizioni di guerra.
La prima era la guerriglia, continui raid e colpi di mano su un nemico statico, costretto a spiegare un numero altissimo di truppe per resistere alla pressione bellica. L’obiettivo, oltre quello di colpire, era fare prigionieri e sottrarre materiale bellico da impiegare per futuri attacchi. Centinaia di prigionieri di guerra marocchini passarono per i campi di rifugiati e più di un migliaio, non riconosciuti da un Marocco che non voleva ammetterne l’esistenza, rimasero fino a giugno 2002.
Il secondo tipo di situazione era la campagna strategica. Questa implicava una preparazione sul terreno con tiri di mortaio e di lanciamissili multipli, lo spiegamento di unità d’assalto con carri T.55 supportati da battaglioni motorizzati sui fianchi; eventualmente più attacchi successivi con lo stesso schema potevano prevedere la presenza di carri dalla seconda ondata. Davanti alla minaccia aerea le unità di combattimento erano dotate di missili terra-aria di tipo SAM. In più le ultime unità coprivano la ritirata minando parti di suolo per evitare contro-attacchi del Reale Esercito Marocchino.
Un ulteriore elemento si aggiunge alle condizioni peculiari della vita militare saharawi: la mobilità continua.
“La vita di ciascuno dipende dalla sua specialità, per esempio un esploratore non vive come un carrista o un artigliere, capisci? Oggi per esempio siamo qui, domani siamo in un altro luogo, è una vita mobile. Oggi fai un’azione militare qui, domani la fai in un altro luogo e così via.
[…] Quasi tutti ci conosciamo tra noi e questo perché? Perché non siamo tanti. Quasi tutti ci conosciamo, questo movimento ti aiuta a conoscere più gente e inoltre è una strategia di movimento.”
“E’ una vita mobile” e lo è a due livelli. A livello esterno – poiché la strategia impone di non esporsi a uno scontro frontale e di tentare di mantenere il controllo dell’iniziativa militare – si traduce in continui spostamenti nel deserto da una base all’altra, da cui preparare e lanciare brevi offensive.
A livello interno significa un continuo ricambio di commilitoni, perché lo spirito di “corpo” – nel senso più generale – resti sempre più saldo dello spirito di reparto. In più, obbedisce anche alla logica del superamento delle tribù, in quanto i soldati si troveranno a combattere fianco a fianco compagni d’armi con appartenenze tribali sempre diverse, rinsaldando i vincoli di unità attraverso la condivisione di un’esperienza comune. Si può rilevare lo stesso disegno – volto a “mescolare” invece che a “separare” – nella disposizione delle famiglie nei campi di rifugiati dove famiglie in tende vicine non appartenevano alla stessa tribù.
Il Muro di Sabbia
La strategia marocchina, perdente fino a quel momento, cambiò radicalmente nel 1982, con la costruzione del Muro. Un tale tipo di fortificazione militare era totalmente estraneo alla storia del deserto, ma la necessità di dare una svolta al conflitto si era palesata con le offensive sempre più pesanti che avevano caratterizzato la fine degli anni ’70. I posti fissi isolati e le piccole guarnigioni si erano rivelate estremamente vulnerabili, perché disseminate nel mezzo di un territorio di cui non disponevano una conoscenza lontanamente pari a quella dei guerriglieri saharawi – considerati addirittura più esperti dei Mauritani. La costruzione del muro rispose all’esigenza di obbligare i guerriglieri a cercare l’ingaggio frontale, procurar battaglia una volta per tutte e arrivare ad uno scontro aperto.
Se forti e fortificazioni, spesso associati a esponenti sufi, non sono estranei alla tradizione islamica – le ribāṭ – il muro è già sul piano concettuale una struttura che non appartiene al Sahara. Quei forti potevano servire da punti di rifornimento per le carovane o i pellegrini, il muro crea una frontiera – sul piano fisico e sul piano mentale – che società nomadiche hanno faticato ad accettare, come visto nel caso dei confini imposti dai colonizzatori europei.
Ciò che è chiamato “Muro” consiste in realtà in un complesso di sei strutture murarie della lunghezza complessiva di oltre 2.720 chilometri, progressivamente costruiti dal Marocco tra il 1982 e il 1987, che inglobarono sempre maggiori porzioni di territorio per cercare di consolidarne il controllo e ridurne la vulnerabilità ai raid del Polisario.
Non è un caso che il primo muro fosse stato costruito a protezione del cosiddetto “triangolo utile” ovvero l’area a nord-ovest, la più importante dal punto di vista economico e demografico, visto che comprende la zona di El-Ayun, Bou Craa, Smara e Bojador.
Il muro è dotato di sistemi di rilevamento di movimento radar AN/PPS-15 ogni 15 chilometri per fornire dati alle vicine unità di artiglieria. E’ protetto nella sua lunghezza da 160.000 soldati marocchini, di cui 65.000 in prossimità del muro e 240 batterie di artiglieria pesante, e costituisce il muro più grande al mondo dopo la Muraglia Cinese. Lungo l’intera struttura corre un immenso e ininterrotto campo minato – che ha il triste primato di essere il più lungo del mondo – e si stima contenga tra i sette e i dieci milioni di mine, ossia 20 mine per ogni Saharawi. Fu Ahmed Dlimi – capo delle operazioni nel Sahara Occidentale dal 1974 – che propose la realizzazione del muro, in collaborazione con gli esperti israeliani (tra cui il generale dello Tsahal Ytzakh Rabin) con cui aveva costanti contatti dal 1963 – nel ruolo di interlocutore del Marocco con il Mossad.
La costruzione del muro venne ultimata nel periodo più difficile per il Marocco: il morale dell’esercito era bassissimo per le continue perdite e la mancanza di una prospettiva di svolta, il paese era sull’orlo del collasso sociale ed economico e alcuni generali cercarono di aprire dei canali per colloqui paralleli con l’Algeria. La CIA, costante protezione del regime marocchino, avvertì il re del pericolo di un nuovo colpo di Stato, ordito da Dlimi con l’appoggio dei servizi segreti marocchini e del Polisario. Nello spazio di una settimana, alcuni generali scomparvero improvvisamente e Dlimi morì in un sospetto incidente vicino Marrakech, il 25 gennaio 1983.
Il muro – almeno nell’immediato – sembrò sortire i suoi effetti e i primi attacchi del Polisario furono rovinosi: la produzione di fosfati – cartina al tornasole dell’andamento della guerra – riprese corso dopo più di sei anni di inattività. Il Polisario a questo punto si trovò davanti alla necessità di adattare la strategia, modificando solo leggermente i sistemi d’attacco che aveva utilizzato fino a quel momento.
“Prima che costruissero il muro il nostro esercito attaccava la capitale El-Ayun, nel Sahara, le zone del Sud del Marocco come Tan-Tan, Smara, Shtur, le miniere di fosfati di Bou Craa. Quando costruirono il muro ci toccò cambiare le carte e le cambiammo. Facemmo una guerra di guerriglia contro il muro. Ogni compagnia, per dire, dell’esercito aveva una quantità di chilometri, 60, 70 80 o dipende dal numero di soldati che ci sono. Nella notte devono andare fino alle mine e fare gli attacchi in quel momento del giorno o della notte, così loro non sono mai tranquilli, per creare un danno, perché ogni munizione che abbiamo noi è presa da loro da qualche parte. Qualche volta la compagnia sceglie un sito dove si ritiene si possa fare un’operazione di grande importanza, ci riuniamo, ne parliamo e entriamo per quella parte di muro e prendiamo tre o quattro basi militari. Le operazioni si differenziano per quanto si riesce a prendere, trenta, quaranta, cinquanta, cento, duecento e così via … E’ come ogni operazione, qualche volta si prende molto, qualche volta meno e qualche volta di più. Per entrare entriamo, sicuro, quando colpiamo entriamo.”
La guerra cambiò in realtà di obiettivo. Consapevoli del costo del muro, gli attacchi erano in qualche caso meno importanti dal punto di vista materiale che da quello psicologico. Che prendessero tre o cento tra basi militari, uomini, materiale, poco importava, perché un altro obiettivo era già stato raggiunto: “così loro non sono mai tranquilli”. Il muro era stato costruito per limitare le perdite umane ed economiche (benzina e munizioni), ma tenere sempre sul chi vive delle truppe che dovevano svolgere solo compiti di difesa corrispondeva a tenere la guerra sempre aperta. Una guerra aperta significava soldati perennemente mobilitati e ciò aveva il suo prezzo. Il dipartimento di Stato americano ha calcolato che il Marocco spendeva nel 1983 circa 1,9 miliardi di dollari al giorno – stime riviste da alcuni al rialzo in alcuni casi fino da 2 a 5 miliardi di dollari al giorno – per proseguire la guerra. I costi scesero a 1 miliardo di dollari al giorno solo dopo il 1987 – quando però si aggiunsero i costi civili (investimenti, stipendi).
Senza aiuti – in particolare di provenienza americana o di altri stati alleati del Golfo – il Polisario contava sull’implosione economica del regime nello spazio di massimo dieci anni.
Non si doveva dare l’impressione – e questo mi è stato categoricamente confermato dalle altre interviste, dove si parlava del muro con una noncuranza quasi eccessiva – che il muro fosse la risorsa decisiva, tanto da costituire una svolta per l’esercito marocchino. L’altra declinazione del fattore psicologico degli attacchi del Polisario era la volontà di tenere in mano l’iniziativa della guerra, prerogativa che il Marocco aveva cercato di sottrarre con la costruzione del muro.
“I Saharawi all’inizio della guerra avevano una tattica, una strategia. L’esercito marocchino supera l’esercito saharawi in quantità di effettivi, armamenti e di molte cose, ma non in volontà, non lo supera, ok? Creare il muro, rappresenta una cosa, che non sono capaci di resistere alle offensive che fa l’esercito saharawi nel territorio marocchino. […] Hanno costruito i muri, però i muri sono poca cosa per noi, perché non sono un ostacolo, perché le azioni militari, fino a che si fecero, si facevano al di là del muro. Si apre una breccia, si apre per tutti, passa la gente, si fa l’offensiva, uccidono chi viene ucciso, catturano quelli che sono catturati e si ritirano. Hanno distrutto molto durante la costruzione del muro e durante il mantenimento perché loro, per la lunghezza del muro, per tutto il Sahara Occidentale, hanno qualcosa come 157.000 effettivi. Noi, che non superiamo i 10.000 effettivi, non abbiamo nessun problema: oggi attacchiamo da una parte, domani da un’altra e così andiamo.
Sì, la strategia è implicito che cambi, non è lo stesso attaccare una forza in un luogo senza ostacoli che attaccarne una dove ci sono ostacoli. Questo cosa ti implica? Ti implica una maggiore anticipazione, più esplorazione e diciamo ti prende un po’ più di tempo, non è lo stesso attaccare senza ostacoli che incontrare degli ostacoli, ma cosa devi sapere o cosa devi fare. Devi sapere la tattica che userai per attaccare. Io credo che implichi solo una diminuzione del tempo, niente più e niente meno. Le offensive che si facevano prima continuarono fino a che terminò la guerra.”
In effetti la vastità delle estensioni desertiche coperte dal muro nascondevano una debolezza intrinseca. Coprire la lunghezza del muro significava uno sforzo sovrumano da parte dell’esercito che – seppur con un numero altissimo di soldati – non avrebbe potuto coprire contemporaneamente tutte le parti, esponendo il fianco ad attacchi ravvicinati nel tempo e lontani nello spazio da parte del Polisario.
La strategia cambiò quindi solo marginalmente. Rimasto inalterato lo squilibrio di truppe, non rimaneva altra possibilità se non proseguire la guerriglia, con un ostacolo in più. Oltre al già citato fattore psicologico, la guerra diventò un’attività continua per necessità logistiche: attaccare il muro significava preparare l’operazione in ogni singolo dettaglio, dato il maggiore pericolo di risposta. Nella pratica questo significava:
“Quando non c’è nessuna operazione di grande importanza noi dovevamo stare nei pressi di quel muro tutta la notte. C’è da levare le mine che possiamo levare, c’è da sapere dove tengono i radar, c’è da fare il possibile per distruggere quei radar. E siamo stati così … quello che ti sto raccontando all’inizio sembra un po’ improbabile o difficile, ma con il tempo diventa più familiare e ti senti come, come se stessi comodo lì. E’ come una cosa che all’inizio è difficile, ma poi con il tempo ti ci abitui.”
La guerra diventa esperienza totalizzante, a tempo pieno, per degli uomini che non sono né pagati né militari di professione, ma che lo diventano in breve tempo in funzione delle necessità della situazione.
Le nuove condizioni – la costruzione del muro – non incidono sulla determinazione degli attacchi saharawi, ma essi si fanno meno frequenti e la guerra continua ancora 9 anni dopo la costruzione dell’ultimo muro, dando fondamento alle tesi di chi definisce il conflitto del Sahara Occidentale come il caso più eclatante di guerra a media intensità dopo la guerra del Vietnam.
Luca Maiotti
Il post precedente è al link Sahara Occidentale: conflitto e identità attraverso le storie di vita dei guerrilleros saharawi, L.Maiotti/9– Detribalizzazione
Seguirà Dall’eliminazione delle referenze tribali alla creazione di nuovi racconti
Foto: lavocedinomas.org