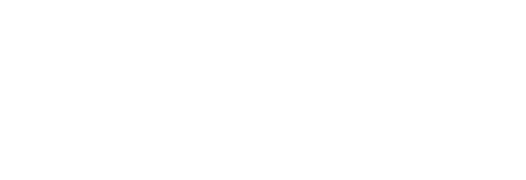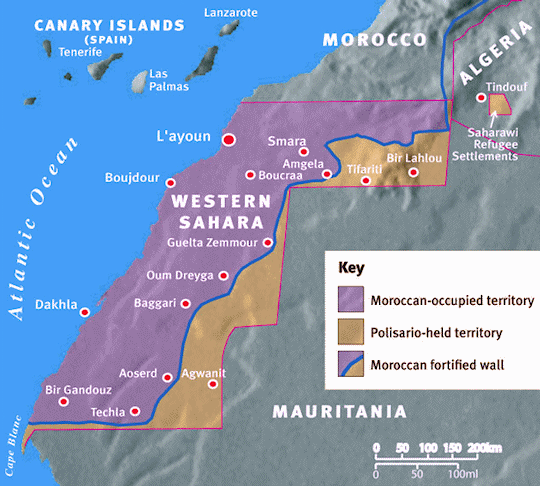Capitolo 2 della tesi Sahara Occidentale: conflitto e identità attraverso le storie di vita dei guerrilleros saharawi – La detribalizzazione e la nascita del popolo: un esperimento sociale
La necessità del popolo
La creazione del Fronte Polisario nel 1973 rispose alla precisa esigenza di dare una forma stabile e coerente al sentimento di rivalsa e agli obiettivi di resistenza contro il colonialismo spagnolo in primo luogo e a quello marocchino successivamente. Il primo successo – forse il più importante – che raggiunse il Polisario fu la mobilitazione della popolazione saharawi per la causa dell’autodeterminazione, proponendo un modello di sviluppo sociale alieno al mondo dei valori tradizionali. Il fenomeno della sedentarizzazione – manifestatosi dopo due intense ondate di siccità e in seguito alla creazione di posti di lavoro nelle miniere di fosfati – aveva già iniziato a cambiare il modo di vita di una parte importante della popolazione saharawi.
Il nomadismo, tratto essenziale della maggioranza delle tribù del Sahara Occidentale, non era stato però eliminato: lavori stagionali permettevano di alternare impieghi stanziali e attività non sedentarie, così come nelle generazioni più antiche ancora mancava l’interiorizzazione di una concezione di entità statuale, nonché di nazionalismo. La presenza del colonizzatore spagnolo non era stata così pervasiva, fino alla scoperta dei fosfati, da piegare una società tribale agli standard europei proposti dagli spagnoli.
Il Fronte Polisario si occupò, attraverso un’opera di propaganda, di una vera “conversione delle coscienze” saharawi, riuscendo a porre le basi di un esperimento sociale che si trasformerà compiutamente in un successo solo negli anni di guerra. Formato dalla convergenza di giovani Saharawi istruiti – il gruppo di Rabat – e da quella parte della popolazione affascinata dai modelli di lotta e di società ispirati ai partiti di sinistra medio orientali, il Fronte si caratterizzò fin da subito per le sue idee di stampo rivoluzionario e terzomondista.
Il primo bersaglio fu quindi – quasi naturalmente – il passato tribale. Questo essenzialmente per due ragioni. La prima era di carattere storico: le divisioni tribali non avevano permesso di costituire un fronte unico di resistenza contro l’invasore coloniale. Nello stesso momento cioè si accostò il periodo di dominazione coloniale al tribalismo – causa di debolezza strutturale in campo politico e militare, in anni in cui molti paesi africani avevano raggiunto l’indipendenza solo attraverso la lotta armata. Esempi come quello dei Ciadiani del Frolinat, o più tardi dei Tuareg, costituivano un monito per i dirigenti del Polisario, perché rappresentavano esempi di movimenti in cui le segmentazioni tribali avevano avuto la meglio sull’unità proclamata contro il nemico comune.
La seconda ragione era di carattere giuridico a livello internazionale. Infatti già nel primo paragrafo della Carta ONU si trova tra le finalità dell’organizzazione quella di “sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale”.
E ancora, nel successivo Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici viene dichiarato dal primo articolo che “tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. In entrambi i testi, noti e accessibili a tutti, a maggior ragione a una parte dei dirigenti del Polisario (il gruppo di Rabat) che aveva studiato Diritto e Scienze Politiche, la parola di riferimento – perché attore dotato del diritto ad autodeterminarsi – è il popolo, non la tribù.
Si potrebbe aggiungere un’ulteriore ragione, di carattere sociale. Quella del Polisario era una strategia che rispondeva da una parte alle esigenze politico-militari della fase storica contingente, ma dall’altra inseguiva una logica di lungo periodo: all’inizio degli anni ‘70 la popolazione saharawi si trovava in una fase non matura per quanto riguarda una “coscienza nazionale”, ma allo stesso tempo non poteva esser più considerata – né si considerava essa stessa – solo un insieme di tribù dalle caratteristiche omogenee.
Ciò che il Polisario fece, fu dare una prospettiva a quello che potremmo definire un sentimento nazionale “senza forma”. Con questa espressione intendiamo che, se da un lato alcuni elementi imprescindibili erano presenti, come testimoniato da vari movimenti (la resistenza di Ma El-Ainin e lo Harakat Tahrir in primis), dall’omogeneità dei costumi, dalla lingua e da un passato comune, dall’altro questa coscienza mancava di consapevolezza, configurandosi come una serie di tensioni essenzialmente monodirezionali che non avevano però un canale di sbocco.
In altre parole la popolazione saharawi si trovava ad affrontare i problemi che dovettero – e devono – affrontare molti Stati africani: il colonialismo aveva inciso profondamente sulla società e in particolare sulle istituzioni; la società, plurale e composita, si trovava a dover scegliere tra un modello di sviluppo alieno al proprio mondo di valori “tradizionali” e nello stesso tempo all’impossibilità di ricreare le condizioni precoloniali. Il Polisario, formato da uomini e donne cresciuti integralmente sotto la colonizzazione spagnola, ma consapevoli dell’organizzazione tradizionale – forse proprio perché si trovavano a vivere questa contraddizione – riuscì a far aderire la popolazione ad uno schema di società “estraneo”, quello della nazione. Attraverso la propaganda da una parte, ma soprattutto attraverso eventi esterni come la guerra e i campi dei rifugiati dall’altra, quello che si presentò come un esperimento sociale unico nel mondo arabo, riuscì a compiersi integralmente, dando vita prima ad un nazionalismo vero e proprio, poi ad uno Stato nazionale.
La detribalizzazione
Così, il problema fu trasformare i legami di solidarietà organica tribale (la ʻaṣabīya di Ibn Khaldun) in nuovi sentimenti nazionali senza che perdessero di vigore, nell’operazione di negazione della tribù. E si scelse il modo più sbrigativo, anche se probabilmente non il migliore: il silenzio.
Per esempio alla domanda “Può parlarmi della sua famiglia? Della sua frazione? Della sua tribù?“ a Bucharaya Salek, che nel 1975 era appena adolescente, la risposta è stata:
“Sì posso farlo, ma non è mia abitudine parlarne. Io sono di una generazione che venne giovane al Fronte Polisario, e che venne su tutta uguale, senza sapere. Quello con cui hai parlato adesso, l’ultimo, è stato con me dal ‘75 all’80 e nessuno dei due sapeva di quale tribù l’altro fosse originario”
Si cercò di cancellare letteralmente dalle memorie il passato tribale, non parlandone più e sostituendo i miti che ne stavano alla base. Il motto, riprodotto sui muri e ripetuto nelle riunioni, fu “il tribalismo è un crimine contro la nazione” e la parola qabīla (tribù) fu cancellata dal vocabolario. In questo senso la generazione di coloro che ho intervistato crebbe “senza sapere”, quindi “tutta uguale”. Partendo da questo egualitarismo programmato, poi imposto dalle condizioni esterne (durante la guerra e nei campi), si realizzò quasi compiutamente l’utopia di creare non un homo novus, ma una classis nova, una intera generazione slegata dal passato tribale, che poi avrebbe dato vita ad una società in cui il singolo non potesse più sapere a quale tribù appartenesse il suo vicino. O, in alternativa, che conoscesse le tribù meramente come attore storico.
Alla stessa domanda “Può parlarmi della sua famiglia? Della sua frazione? Della sua tribù?” mi aveva infatti risposto Hamdi Abderrahmad:
“Generalmente la struttura sociale del popolo saharawi si compose di tribù, in ogni tribù ci possono essere delle frazioni e una frazione può avere anche delle sub-frazioni. Generalmente le tribù che composero la struttura sociale del popolo saharawi sono i Rguibat, i Tekna, gli Ould Delim, poi in generale le tribù con questi nomi sono composte di frazioni. Capito? Io ho detto le tribù principali, però ci sono altre tribù che non conosco, ma generalmente queste sono le tribù che composero ciò che è il popolo saharawi”
In maniera estremamente generale, e molto poco approfondita, mi è stato presentato il mondo tribale come qualcosa di definitivamente chiuso, passato. Se ciò può apparire scontato agli occhi di una società occidentale, esso rappresenta decisamente uno strappo non di poco conto in molti Stati dove ancora oggi la tribù esprime l’unico ambiente in cui l’uomo trova il suo sviluppo (primo tra tutti la vicina Mauritania). Ali Salek, alla stessa domanda, ha risposto:
“La tribù qui non è importante se le interessa la causa dei Saharawi, perché la tribù è una forma molto antica, non vale per niente, ci sono moltissime tribù che si trovano nel Sahara, perché si compongono di tribù tutti i paesi arabi, ma noi qui stiamo parlando di una causa più importante”
La soluzione di mantenere il silenzio su una parte del proprio passato recente fu dettata dalla tempestività del precipitare della situazione e dalla necessità di riformarsi per evitare di essere attori passivi davanti agli eventi.
Negli ultimi anni si sta comunque affermando un discorso “riparatore”, che considera troppo radicale la scelta del silenzio da parte del Polisario, in quanto non lasciò spazio a soluzioni più sfumate o graduali. Il poter ragionare di nuovo di differenze all’interno della società saharawi è dovuto al fatto che il Marocco ha ottenuto che le liste a disposizione della MINURSO per il referendum classificassero i Saharawi secondo le linee tribali, creando il pericolo di una segmentazione della società. E’ comunque innegabile che la strategia del Polisario si rivelò vincente nel breve periodo e i Saharawi diedero prova di coesione praticamente senza eccezioni sia sul campo di battaglia che tra le tende sull’hammāda di Tindouf.
La terza generazione, nata e cresciuta nei campi dei rifugiati, ha conservato come quella precedente la sua memoria storica “corta”. Per esempio a Rachid Lehebib, nato nel 1988, una volta saputo il nome della tribù alla quale apparteneva la sua famiglia, ho chiesto che cosa sapesse dei Tekna. La sua risposta è stata:
“No, alla gioventù che è cresciuta lottando nei campi dei rifugiati, non interessa. La tribù non è interessante per noi perché abbiamo combattuto per un paese e per tutte le tribù e per tutti i Saharawi; non c’è interesse per la tribù nella nostra vita. La tribù è come uno delle tante cose tradizionali del paese, non è molto importante e tanta, tanta, tanta gente in Sahara Occidentale, giovane, ma in realtà anche vecchia, non è interessata a queste cose. Ma gli anziani sì, agli anziani interessavano queste cose, gli anziani con le storie delle tribù del Sahara Occidentale”
La frase di apertura è già rilevante, perché Rachid si sente di appartenere “alla gioventù che è cresciuta lottando nei campi” – nonostante evidentemente non si possa riferire alla guerra, visto che al momento del cessate il fuoco del 1991 aveva solo tre anni – e da ciò si possono trarre due indicazioni. La prima è che ormai la lotta per l’autodeterminazione ha pienamente sostituito nell’epica nazionale qualunque mito di fondazione tribale e quella che è stata la lotta dei padri è diventata il patrimonio storico comune di un’intera società. La seconda è che i Saharawi hanno avuto fin da subito una concezione attiva dell’esilio, dando vita a dei campi di rifugiati ordinati, funzionali e dignitosi, nonostante siano stati concepiti come provvisori – più di trenta anni fa.
Successivamente, sempre nella parte di intervista riportata, Rachid introduce il problema degli anziani. Il ferreo rispetto degli anziani è stato l’unico elemento, insieme all’etica guerriera, mutuato integralmente dalla tradizione tribale. Slama Amarna dice:
“Tutti noi ci caratterizziamo per alcune cose che non si trovano in tutto il resto del mondo, noi rispettiamo gli anziani. Per noi i nostri padri, le nostre madri, sono qualcosa di sacro, bisogna rispettarlo al massimo”
Così, se il modello rivoluzionario fu rapidamente interiorizzato dalle nuove generazioni, restava al Polisario guadagnarsi l’investitura degli anziani, senza la quale sarebbero rimasti poco più di una minoranza. Per coinvolgerli nel progetto di fondazione nazionale però, il Fronte dovette adattare per loro – e in realtà per tutta la popolazione – gli slogan e le idee perché non risultassero troppo estranee, operando una traduzione lessicale e quindi concettuale di termini non appartenenti al vocabolario e al pensiero tribale.
Le parole della detribalizzazione
Il passaggio concettuale fondamentale era in particolare la trasformazione dal plurale “insieme delle tribù” al singolare “popolo”, un soggetto unico intorno al quale si sarebbe costruito lo Stato del Sahara Occidentale.
Come sostiene Sophie Caratini, la parola araba per popolo, sha’ab, si riferisce in generale alla nazione sorta dalle lotte anticoloniali. In Medio Oriente in particolare il termine veniva usato da coloro che si opponevano al progetto nasseriano di un unico Stato arabo (il popolo arabo/i popoli arabi) e indicava la nazione in antitesi alla dottrina politica pan-araba.
Ummah, da qualcuno tradotto con nazione, in realtà ha la sua migliore trasposizione in comunità, implicitamente quella dei credenti. La parola sha’ab poteva anche essere usata in senso identitario per nazioni in opposizione allo Stato locale, come i Kurdi, gli Armeni e ovviamente i Palestinesi, che sono stati per lungo tempo lo sha’ab per eccellenza.
Quest’ultima sfumatura in particolare sarebbe stata sufficiente per i dirigenti del Polisario, ma non per la popolazione o gli anziani, che avevano bisogno di un rimando semantico e concettuale più vicino: si decise di spiegare che essere sha’ab significava formare una ‘asaba waḥda, un solo gruppo di parentela. ‘asaba, indica il legame di consanguineità trasmesso per via patrilineare, il patto “naturale” che risulta da una idea di sangue comune; waḥda significa uno, unico.
Questo concetto si lega all’espressione locale ‘usma waḥda, ugualmente ripresa dal Polisario. Letteralmente fa riferimento alla correggia di cuoio tesa tra i due picchetti della tenda per mantenerne l’equilibrio, ma in senso figurato simbolizza l’unità organica delle parti, che non hanno altra scelta se non quella di organizzare insieme la propria difesa per evitare il crollo.
Al posto dei riferimenti di sangue si utilizzò la parola “rafīq”: non ci sarebbero stati né fratelli, né sorelle, né cugini, ma soltanto “compagni”, lasciando fuori causa il principio guida del sangue, fondamentale per il tempo nomadico, quando questo potesse spaccare la società.
Come visto, la solidarietà di gruppo venne usata come riferimento identitario a livello generale per rendere l’idea di fratellanza nazionale, ma venne lasciata cadere nelle dinamiche interne della società, perché non richiamasse più frazionamenti per gruppi agnatici.
La rivoluzione copernicana saharawi
La faticosa opera di traduzione concettuale, sensibilizzazione e propaganda, tutta a livello interno, portò i suoi frutti. Sulla spinta di eventi esterni – la partenza degli spagnoli e l’azione interessata del Marocco alla Corte Internazionale dell’Aja – si giunse velocemente alla decisione di realizzare la detribalizzazione, ponendo in atto una vera e propria “conversione delle coscienze”. Con questa espressione facciamo riferimento alla rivoluzione copernicana a livello del singolo che fu posta intenzionalmente in atto da tutti i componenti della società saharawi. L’espressione “rivoluzione copernicana” non è qui usata casualmente: come Kant la riprese in senso filosofico , qui la utilizziamo in senso sociale, intendendo il vero e proprio cambio di paradigma intercorso prima a livello unitario, quindi generale, nella società saharawi.
Per approfondire questo punto è necessario soffermarsi sul ruolo del singolo nel passato tribale. Per meglio definirlo si riprende qui la concezione del singolo nelle società del sud est asiatico, in quanto alcune categorie concettuali possono essere riprese in analogia con le tribù arabe.
Fino a quel momento la maggioranza degli studiosi considerava il singolo “homo hierarchicus”, cioè inserito in una società pensata come scala castale che aveva due poli alle sue estremità, uno di massima purezza e uno di massima impurità. A questa teoria rispose criticamente McKim Marriott inserendo nel dibattito il concetto di “dividuo”. Fino a quel momento ci si era confrontati solo con una concezione di personalità “europea”, che presentava l’individuo come un unicum che si autodetermina, un singolo ben definito che ha in sé il suo riferimento. Al contrario, il dividuo può essere pensato come il risultato di più interazioni e autori diversi, creato da “codici sostanziali” (sangue, cibo, tipo di conoscenza, cottura dei cibi) che sono trasmessi attraverso corpi, persone e caste. I codici sostanziali si mescolano con le persone, ma appartengono al mondo “esterno” e circolano e si trasformano costantemente attraverso le interazioni sociali. Ciò comporta che queste sostanze esterne, date e ricevute, operino dei cambiamenti sulla persona a livello interno. La definizione del sé passa quindi per esempio nelle tribù sahariane per il codice sostanziale del sangue – sintetizzato nella formula “io contro mio fratello, io e mio fratello contro mio cugino, io, mio fratello e mio cugino contro lo straniero”- che rappresenta un “materiale biogenetico condiviso”. La caratteristica di questa concezione di dividuo è che il riferimento fondamentale della persona non è mai se stessa, ma appunto il codice sostanziale – che eventualmente può essere non uno solo, ma di più tipi. Ora, la gerarchia è soltanto la facies di una società costruita sul sangue, dove, per esempio, è logico che la figura degli anziani sia sacra e addirittura lo stesso sangue appare solo come uno dei codici sostanziali possibili. Più codici sostanziali interagiscono per creare l’identità della persona, che è definita ogni volta solo in funzione di questi codici. Non è un caso che la stessa parola persona derivi etimologicamente dalla parola maschera, quasi a dare l’idea di poter disporre di tante identità come di tante maschere, a seconda del ruolo – o del codice sostanziale – che si prenda a riferimento. La logica meticcia di Amselle, come ricordato nel primo capitolo, riprende questa teoria.
La “rivoluzione copernicana” della concezione di persona dei Saharawi consiste nell’ esser riusciti a stravolgere non tanto l’oggetto dei riferimenti o i codici sostanziali, quanto piuttosto il modo di guardare il sé, la prospettiva identitaria. Se Copernico cercò di “indagare i movimenti celesti facendo star fermi gli altri e ruotare l’osservatore”, l’operazione della dirigenza Saharawi fu della stessa portata, ma con direzione contraria. Il singolo non si autodefinì più in funzione degli altri, secondo codici sostanziali “mobili” e plurali, ma concentrò in sé il suo punto di osservazione – prima decentrato – per fermarsi a referenti identitari fissi. Se volessimo continuare la similitudine con la teoria di Copernico, la nuova concezione dei Saharawi fu piuttosto una teoria geocentrica, dove ogni pianeta – il singolo -, ognuno con il proprio punto di auto-osservazione in se stesso, non aveva più bisogno di codici sostanziali mutevoli, ma fissi e spesso ideali (Nazione, Stato, Territorio). Il passaggio da dividuo a individuo era completo. Se questo fenomeno – generalmente chiamato detribalizzazione – fu teorizzato forse anche inconsciamente sul piano ideale, sul piano storico-materiale fu più difficile e lungo da realizzarsi – alcune “scorie” del passato rimasero – ma sicuramente poté considerarsi in larga parte concluso soprattutto in seguito alle esperienze della guerra e dei campi dei rifugiati.
Dal punto di vista storico il passaggio si effettuò a Ait ben Tilli il 12 ottobre 1975 – una delle tre date fondamentali dell’anno saharawi – quando giovani e anziani di tutte le tribù, proclamarono solennemente l’”unità nazionale”, proclamando anche la fine del PUNS – il partito creato dalla Spagna. Poco più di un mese dopo a Guelta Zemmour fu votato anche lo scioglimento della Jema’a – consiglio direttivo investito di autorità dagli spagnoli nel 1967, pallida emulazione del consiglio dei capi dell’era tribale – per non rendere più possibile lo sfruttamento a fini politici della struttura; nonostante ciò, il Marocco la riconvocò, senza la maggior parte dei membri che avevano aderito definitivamente al Polisario, in una riunione la cui legittimità fu decisamente negata dal Fronte. Anche per questo motivo si decise di proclamare, proseguimento del percorso di cambiamento della coscienza saharawi, la nascita della Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD) il 27 febbraio 1976 – altra data cardine. Con questo atto si sancisce a livello politico la creazione di un soggetto giuridico riflesso di un attore sociale dalla volontà univoca, il popolo saharawi.
“Chi sei?”
In una conversazione con un Saharawi ci si aspetterebbe sistematicamente che costui cerchi di collocarsi genealogicamente rispetto all’interlocutore, chiedendogli l’appartenenza etnica, la sua confederazione fino al nucleo familiare e la “gerarchia” della tribù. Alla domanda “Se dovesse raccontare brevemente chi è lei, che cosa risponderebbe? Se dovesse presentarsi in poche parole” le risposte sono state:
(1) “Mi chiamo Hamdi Abderrahmad, sono un Saharawi di nazionalità spagnola, sono nato El-Ayun nel 1968. Lasciai El-Ayun, capitale del Sahara Occidentale con la mia famiglia e altre migliaia di Saharawi verso il sud.”
(2) “In linea, diciamo, generale, diciamo che siamo tutti Saharawi. Ci sono alcuni per esempio che sono ex militari del Polisario e altri che hanno lavorato nei campi civili. Se vuoi che ci presentiamo per nome e cognome, io mi chiamo Slama, sono del Sahara Occidentale, del Fronte Polisario, sono un ex combattente nella seconda regione di fanteria motorizzata.”
(3)“Mi chiamo Bucharaya Salek Omar e sono di El-Ayun, la capitale del Sahara occidentale. Sono nato nell’agosto 1959. Nel 1975 fui tra quelli che abbandonarono il Sahara per l’accordo che ci fu tra il governo spagnolo, il Marocco e la Mauritania.”
(4)“Chi sono io? Sono un combattente del Polisario. Me ne andai da Madrid al Polisario, fui combattente nelle zone liberate del Sahara Occidentale fino al 2000, dal ‘75 al 2000.”
(5)“Io sono un Saharawi, sono un ex combattente nel Sahara, nella guerra del Sahara. Mi chiamo Ali, ho studiato alla base militare e sono ufficiale. Ho lottato gli ultimi dieci anni.”
La scelta di queste interviste è giustificata alla luce di una certa omogeneità: tutti fanno parte della stessa generazione – quella cresciuta “senza sapere” – e tutti hanno affrontato l’esperienza della guerra nonché quella dei campi. Da una prospettiva esterna, essi sono il perfetto risultato dell’azione sociale del Polisario. Tenendo fermo che l’approccio qui utilizzato non è statistico, ma di tipo storico e antropologico, si possono trarre alcune indicazioni.
La prima è che non appare in nessun caso alcun riferimento alla tribù, segno che quindi la detribalizzazione può considerarsi uno stadio già raggiunto.
La seconda si può trarre dalla semplice forma delle risposte. Generalmente la struttura della prima frase – la più immediata, quindi quella sui cui si riflette di meno – è composta dal nome e dalla dichiarazione di essere saharawi. Ma in ben tre casi (2, 4, 5) l’ordine è addirittura inverso a quanto ci si potrebbe aspettare: la prima informazione è l’appartenenza saharawi, la seconda è il nome, quando normalmente dovrebbe essere il contrario. Se aggiungiamo che Bucharaya Salek (3) mi era stato appena presentato come guerrillero saharawi da un commilitone troviamo una schiacciante maggioranza (4/5) che, presumibilmente senza intenzione, mettono al primo posto nella presentazione di se stessi la fierezza di essere Saharawi, persino prima del nome. Ciò è facilmente spiegabile sia per l’opera di “conversione delle coscienze”, ma anche per il fatto che la nazionalità saharawi è stata – ed è ancora oggi – l’enjeu, la posta in gioco, la ragione di essere della questione saharawi. A maggior ragione, bisogna considerare riuscito il trasferimento-traduzione concettuale della solidarietà “naturale” – la ‘asabiyya – nel sentimento di appartenenza nazionale, senza che questo vada a creare spaccature interne.
Il terzo elemento rilevante di queste interviste è la storia comune: quella dell’abbandono della casa – “la capitale” El-Ayun, diventata praticamente un luogo mitico perché fissato nei ricordi – e la nostalgia del Sahara Occidentale come territorio. Qui è possibile vedere un’altra sfaccettatura del fenomeno di detribalizzazione, ovvero il cambiamento del riferimento identitario. Nell’epoca precoloniale il patto sociale che fonda la società nomadica è l’ideologia del sangue: lo stesso gruppo tribale si definirà come la discendenza patrilineare di un antenato comune. Ora il nuovo scenario mostra che il riferimento collettivo è il suolo, uno spazio definito e distinto (la capitale, Madrid, El-Ayun), elemento che sarebbe stato impensabile in un popolo di nomadi. Il limite e la frontiera non avevano mai fatto parte del vocabolario di moltissime popolazioni – nel Sahara Occidentale, ma anche nel resto dell’Africa e in Asia – fino al momento della colonizzazione e non avrebbe avuto senso prendere come riferimento porzioni di terra perché ci si spostava continuamente.
L’altra esperienza comune è la guerra (2,4,5). Insieme al rispetto per gli anziani, l’altro elemento mutuato integralmente dal passato tribale è il ruolo di guerriero del maschio – ma ci sono stati anche casi di donne che combatterono. E’ vergognoso per il maschio restare indietro mentre gli altri sono a combattere. Nell’intervista numero 4 e 5 l’essere combattente rappresenta la prima informazione da dare, ancora prima del nome. Addirittura Najem Mahajub (4) si definisce “combattente” e non ex combattente (5) del Polisario, segno che il passato militare è vivo e attuale nella definizione del sé di questa persona o che le armi sono solo uno dei mezzi con cui si conduce la lotta nazionale saharawi.
Luca Maiotti
Il post precedente è al link Sahara Occidentale: conflitto e identità attraverso le storie di vita dei guerrilleros saharawi, L.Maiotti/8– Ancora tanti argomenti tabù aspettando un referendum da oltre vent’anni
Seguirà L’identità alla prova della guerra
Foto: Arcs