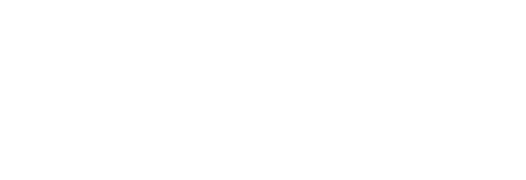pubblicato da Pagine di Difesa il 16 dicembre 2005
Dal prossimo 15 dicembre i militari del contingente italiano svolteranno a destra appena usciti dall’aeroporto: direzione Butmir. Non più verso la città di Sarajevo percorrendo il viale dei cecchini, dunque, poiché la loro caserma non sarà più la centralissima Tito Barracks. Quella che è stata riconosciuta come la casa degli italiani per dieci anni sta per essere restituita al governo bosniaco.
“Si chiude una pagina di storia dell’Esercito Italiano” commenta il colonnello Francesco Diella, che dal 15 giugno è al comando del 17° reggimento artiglieria contraerei ‘Sforzesca’ di Sabaudia ed è attualmente comandante del contingente italiano in Bosnia. Il 15 dicembre Diella cederà il comando del contingente al colonnello Antonio Rendine, comandante del 7° reggimento bersaglieri di Bari. Da allora il contingente italiano sarà a Camp Butmir, a qualche chilometro dal centro di Sarajevo e dalle due torri commerciali che con i loro led luminosi indicavano ora, data e temperatura ai militari della Tito.
“La Tito consentiva al militare appena arrivato di avere subito un impatto con la città – spiega Diella – e con la parte più significativa di Sarajevo; usciti dall’aeroporto cittadino si svoltava a destra e si percorreva un lungo tratto del viale dei cecchini passando di fianco al fiume Miljacka e ai palazzi scheletriti dell’Onu e del Parlamento”. Il viale dei cecchini, meno noto con il suo nome di via maresciallo Tito, è stato nominato spesso nelle cronache di dieci anni fa. Lì si accaniva l’attività di cecchinaggio contro chiunque lo percorresse nel periodo che va dal 1992 alla primavera del 1996. Era il periodo dell’assedio di Sarajevo e il passaggio dei pedoni sul viale veniva protetto da container e coperte stese sui fili tirati da cassone a cassone.
“La prima immagine che ebbi della città fu proprio quella. La situazione appariva tranquilla, ma la gente era tesa perché il futuro, dopo gli accordi di Dayton che portavano a una suddivisone territoriale non corrispondente alla situazione esistente, era una grande incognita”. Così ricorda il generale di divisione Sandro Santroni, nel 1995 colonnello, a capo di un distaccamento avanzato di una quarantina di uomini: i primi militari del contingente italiano ad arrivare a Sarajevo nell’ambito della missione Nato.
“In realtà – chiarisce Santroni – arrivammo in città alla vigilia del passaggio di responsabilità dall’Onu alla Nato e non mostravamo ancora le nostre insegne dato che ufficialmente c’erano ancora i caschi blu che stavano alla Tito Barracks”. Con Santroni nei primi giorni a Sarajevo c’era anche il suo superiore, il generale di brigata Agostino Pedone, oggi generale di corpo d’armata in pensione.
“Fu proprio ai caschi blu francesi che chiedemmo accoglienza per la notte – continua il generale Santroni – e la Tito fu il nostro primo letto”. Quei primi italiani a Sarajevo rimasero alla Tito una decina di giorni, “il tempo di sistemarci all’hotel Bjokovo a Vogosca, un comune abitato da serbi ma destinato a divenire entità etnica musulmana per effetto degli accordi di Dayton”.
Santroni comandava un distaccamento con mansioni logistiche: “Il nostro compito era trovare alloggio per il grosso del contingente che sarebbe arrivato dall’Italia per la missione Ifor (Implementation Force) della Nato. I militari italiani dovevano sistemarsi sia in area serba che in area musulmana, proprio per garantire l’osservanza degli accordi di Dayton”.
“Si trattava di una missione del tutto nuova – racconta il generale Agostino Pedone – sia perché fu a carico di noi militari la ricerca dei compound e degli alloggi dove sistemare il contingente italiano sia perché la Nato interveniva per la prima volta al di fuori del proprio territorio di giurisdizione e al di fuori del proprio mandato”. Il generale Pedone ricorda le difficoltà dovute al mancato riconoscimento della Republika Srspka da parte del ministero degli Esteri italiano: “Dovevamo andare a firmare tutti i contratti per gli alloggi a Pale, là ogni trattativa veniva filmata dalla televisione serba e riprodotta a Sarajevo”.
Pedone rientrò in Italia dopo i primi giorni e quando a metà gennaio 1996 tornò a Sarajevo fu per andare a comandare un complesso di forze che comprendeva il battaglione logistico e l’ospedale da campo alla Tito Barracks. “Alla Tito si erano installati dei civili bosniaci di etnia musulmana – riferisce il generale riportando un episodio inedito – senza domandare niente a nessuno. Sembrava che non se ne volessero più andare e così ponemmo loro un ultimatum. Era pronto un piano per intervenire con la forza, ma prima dello scadere della mezzanotte del 19 marzo 1996, ora e data dell’ultimatum, se ne andarono”.
“La caserma Tito è diventata un piccolo pezzo di Italia a Sarajevo – ricorda ancora il colonnello Diella, ultimo comandante della casa degli italiani – ed è un punto di riferimento non solo per i cittadini ma anche per tutti gli italiani che lavorano a Sarajevo”. E’ un luogo di lavoro per molti sarajeviti che qui hanno trovato impiego nel settore dei servizi.
Kanita Focak, architetto da otto anni interprete con gli italiani alla Tito, ha visto tutte le trasformazioni che si sono susseguite a Sarajevo e nella caserma. “La Tito fu consegnata al contingente italiano in condizioni pessime: era devastata in quanto presa a bersaglio nel corso della guerra. Oggi la palazzina centrale è utilizzata per scopi culturali in connessione con l’università di Sarajevo”. La caserma subisce ora una nuova trasformazione per uso civile. Il sito “costruito nel 1878 dagli austro-ungarici – dice Kanita – verrà restituito al governo bosniaco entro giugno 2006. La sensazione è che si stia chiudendo una pagina di storia”.